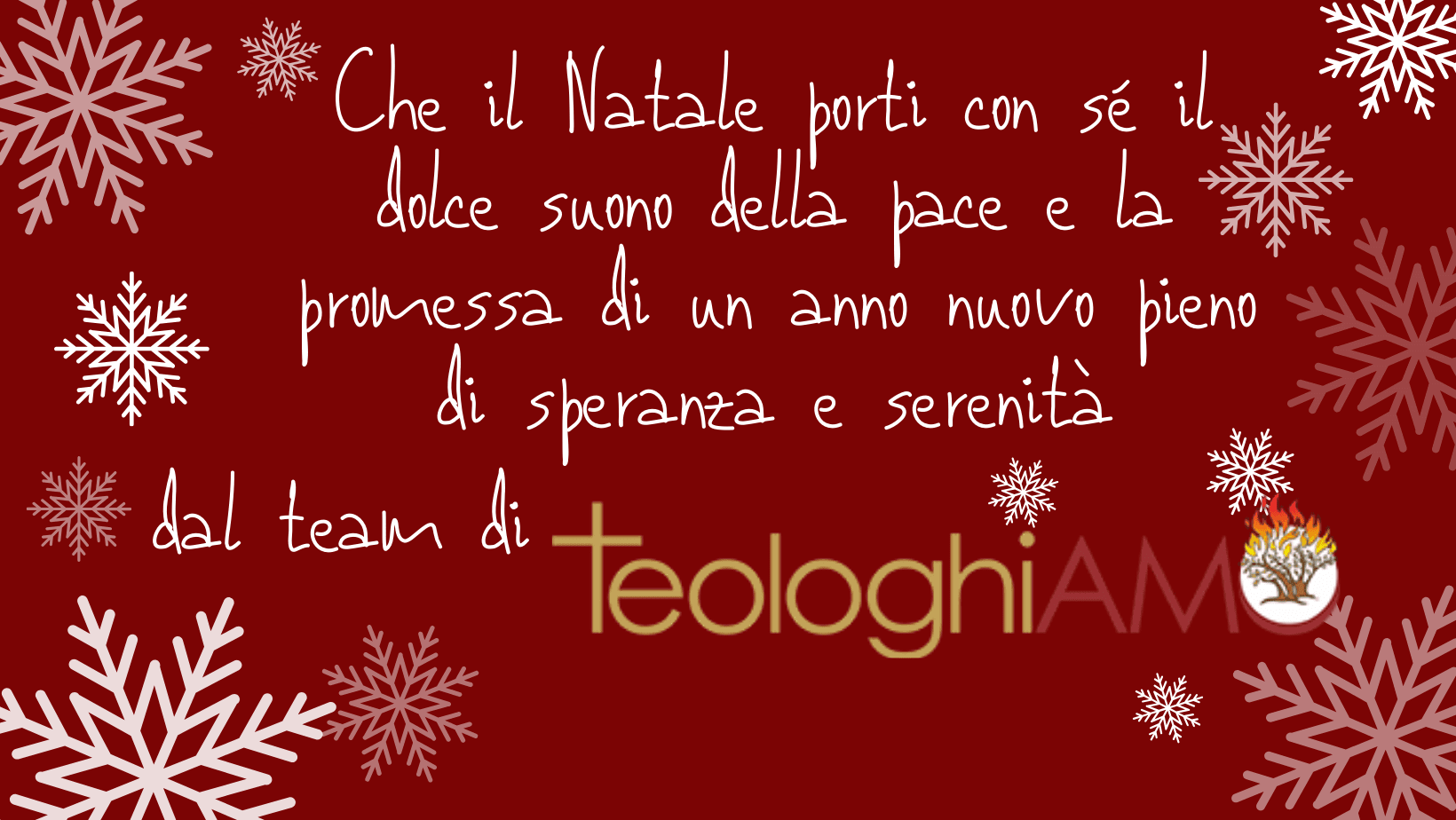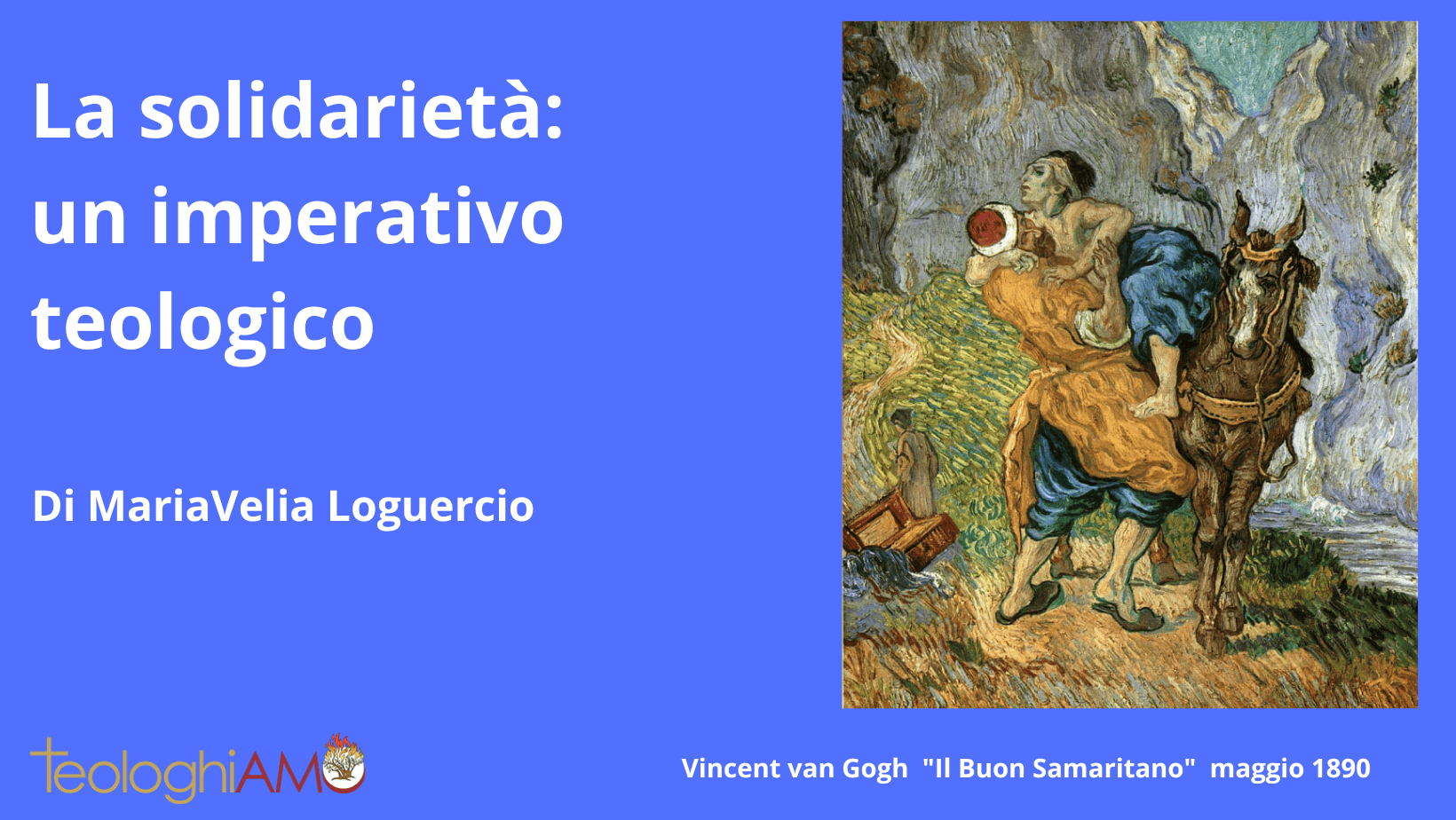Il concetto di solidarietà ha origini antiche, nozione e terminologia infatti derivano dal diritto romano, in cui obbligazione solidale (in solidum) designava quel vincolo giuridico che univa tra loro in modo profondo vari contraenti, in modo che ognuno di essi fosse chiamato a rispondere per l’intero e non soltanto per la propria parte.
Con questa accezione è entrata a far parte degli ordinamenti legislativi attuali che si ispirano al diritto romano. Lentamente questo concetto di natura giuridica si è allargato alla sfera pubblica e in particolare alle relazioni sociali nel loro aspetto basilare di fratellanza, interdipendenza, corresponsabilità universali. In quest’ultima e più rilevante accezione è presente in diversi ordinamenti costituzionali, tra cui quello italiano.
Partirei subito da una constatazione che è sotto gli occhi di tutti: oggi il tema della solidarietà è estremamente attuale per un verso eppure estremamente inattuale per un altro.
Attuale perché forse mai come oggi si è tanto parlato di solidarietà, che è comunemente accolta come un valore, inattuale perché dobbiamo constatare nella nostra società una grossa crisi di solidarietà che si registra di fatto nel vissuto delle persone.
La crisi della solidarietà
Le ragioni di questa crisi della solidarietà sono molteplici, affondano le radici sia nell’attuale complessità sociale, sia in fattori di tipo culturale, politico, economico. Ovviamente non possiamo analizzare in maniera puntuale questa situazione, ma vorrei soffermarmi su uno dei fattori culturali che ha generato questa crisi: questo fattore è l’individualismo.
La nostra è infatti una cultura nella quale prevale la tendenza al ripiegamento del soggetto su sé stesso, sulla soddisfazione dei propri bisogni e dei propri desideri. Le parole d’ordine che caratterizzavano la cultura e la società solo qualche decennio fa erano: impegno, partecipazione, confronto, rivoluzione; oggi invece la società e la cultura sono dominate da ben altre parole d’ordine: desiderio, autorealizzazione, interesse, indifferenza, post, like…parole che a ben vedere hanno a che fare con la centralità della sfera soggettiva.
Oggi quindi tendono ad affermarsi atteggiamenti fortemente individualistici che sono, a ben vedere, in antitesi con qualsiasi cultura della solidarietà. Laddove viene accentuato il bisogno soggettivo quasi fino a mitizzarlo, il principio del “Vale ciò che vale per me come individuo”, si giunge ad una negazione della relazione che porta di fatto a non vedere più l’altro.
Inoltre lo sviluppo delle tecnologie, l’eccessivo utilizzo dei social, per quanto possano avere indiscutibili e innumerevoli vantaggi, non fanno altro che chiuderci in una realtà fittizia che ci discosta da quello che è il contesto reale.
In questo scenario contemporaneo alquanto complesso, segnato da crescenti disuguaglianze sociali, che vede le persone meno abbienti impoverirsi sempre di più, si afferma l’urgenza di sviluppare atteggiamenti sempre più solidali, non semplici gesti vuoti di significato fatti a volte solo per alleggerirci la coscienza, ma un modus operandi che ci veda impegnati, costantemente, nella costruzione di una società più equa, giusta, al servizio del bene comune come ci ricorda anche la dottrina sociale della Chiesa.
Cosa significa solodarietà?
Se questa è la situazione, oggi cosa significa solidarietà? Essa è anzitutto un valore umano, che trova però un significato più profondo, ulteriore, nella prospettiva cristiana.
In prospettiva teologica infatti essa si radica nell’essenza stessa di Dio, rivelatosi come Dio solidale attraverso la storia della salvezza. Questo concetto trascende la mera etica umana, configurandosi come valore teologale che interpella la fede e l’agire del credente.
Nella prospettiva cristiana, che è quella biblica, il cristiano è chiamato a vivere la solidarietà anzitutto perché fa esperienza di un Dio che nei suoi confronti si è rivelato come un Dio solidale. Già nel momento della creazione, poi quando Dio stringe l’Alleanza con Israele mostra la sua solidarietà nei confronti dell’uomo intervenendo continuamente e concretamente nella storia.
Questa solidarietà di Dio nei confronti dell’uomo trova il suo culmine nella vita e nel messaggio di Gesù di Nazareth, Egli incarnandosi diventa pienamente solidale con l’umanità fino a dare per essa la sua stessa vita. Lui, l’Emmanuele, il Dio con noi, si fa carico delle necessità e dei pesi di tutti assumendo il bene dell’altro come proprio criterio esistenziale.
Solidarietà e filantropia
Proprio per questo la solidarietà si distingue dalla filantropia, intesa come amore per il prossimo orientato al benessere, per il suo fondamento nella carità (agape), e la carità è la capacità di vedere, di riconoscere nell’altro il volto stesso di Cristo. Mentre la filantropia può limitarsi a un atto umanitario, la solidarietà biblica è partecipazione alla vita divina
Ma in che senso?
Nella visione cristiana non esistono la “solidarietà” e la “condivisione” se non si parte dall’Amore che è la sorgente di tutto. Nella prima lettera di Giovanni (4,8) si legge: “Dio è amore”, questa affermazione rappresenta il punto più alto della rivelazione dell’essere di Dio.
Nella prospettiva cristiana Dio non è un essere solitario, ma è tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo che esistono e sussistono nell’atto di amarsi. E’ questo amore coinvolgente, dinamico, aperto, che porta Dio a creare l’umanità, ed è la scoperta di questo amore che sempre precede ogni atto umano, che rende indispensabile all’uomo la vita nell’amore.
Quando l’uomo si relaziona con l’altro nell’amore realizza pienamente quell’immagine di sé che Dio ha impresso in lui, manifestando concretamente il dinamismo dell’amore trinitario. Il resto viene di conseguenza: l’amore non si esprime a parole, ma si rende concreto in fatti, atti, tempi dedicati al servizio dell’altro a imitazione di Cristo che per essere grande si è fatto servo di tutti.
La solidarietà del samaritano
Pensando alla solidarietà mi sovviene alla mente uno dei passi evangelici più famosi, il passo è quello di Lc 10,25-37: la parabola del buon samaritano.
Sono passati più di 2000 anni da quando Gesù ha raccontato questa parabola, ma nonostante i grandi cambiamenti storici e culturali avvenuti, il racconto conserva la sua attualità e forza ispiratrice.
Analizzando il racconto si ritiene che il mal capitato sia l’unico ferito della vicenda in quanto “incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto” (Lc 10,30).
In realtà ognuna delle figure del racconto risulta ferita: i briganti sono socialmente feriti perché probabilmente vengono da famiglie segnate dalla povertà e dalla violenza; il levita e il sacerdote sono feriti dai condizionamenti religiosi del tempo, che ne mortificano il cuore e l’umanità, essi sono specchio di coloro che attenti alle formalità sono carenti di umanità; infine anche il samaritano è ferito a livello sociale perché appartiene ad un popolo giudicato dagli ebrei come impuro, eretico ed emarginato.
Eppure il samaritano è l’unico che riesce a trasformare la sua ferita in solidarietà. Il racconto dice che tutti e tre i protagonisti videro il malcapitato, ma ognuno di loro lo vede con occhi e cuore diversi. In realtà i primi due guardano di sfuggita e passano oltre, non riescono davvero a vedere, l’unico che vede davvero, che riesce ad andare oltre è il samaritano che dalla scena si sente interpellato, che non rimane indifferente.
Che grande piega è oggi l’indifferenza!
Nel volto di quell’uomo morente il samaritano vede un fratello e per questo ha compassione, cum- patire significa percepire, sentire come propria la sofferenza degli altri. Proprio perché il samaritano sente quella sofferenza, gli si fa vicino, gli si fa prossimo, agendo in maniera concreta, sporcandosi le mani.
Gesù alla fine della parabola dice: “va’ e anche tu fai lo stesso”. Ed è quello che questo testo ripete ad ognuno di noi quando ci accostiamo alla sua lettura.
Ecco, la speranza e l’augurio è che tutti noi riusciamo sempre ad andare al di là delle logiche individualistiche e soggettivistiche che governano questa società, per poter vedere davvero nell’altro un fratello e in lui l’immagine di Dio, poter davvero avere compassione delle sofferenze materiali e spirituali dell’altro, sentirle come nostre, per poterci smuovere e per agire.
Ti potrebbe interessare anche:
È giunto il Messia?
Aprile 30, 2024Il festival alla Cavour
Febbraio 11, 2024La notte di San Giovanni, tra tradizioni popolari, riti e un pizzico di magia.
Giugno 23, 2024Genitorialitá e immagine divina violata
Novembre 19, 2025Le perle ai porci
Aprile 23, 2024Teologa, studiosa di ebraismo e appassionata di astronomia. Impegnata da anni nel dialogo Interreligioso, docente di religione e docente di ebraico ed esegesi dell’A.T. presso ISSR San Matteo (SA).