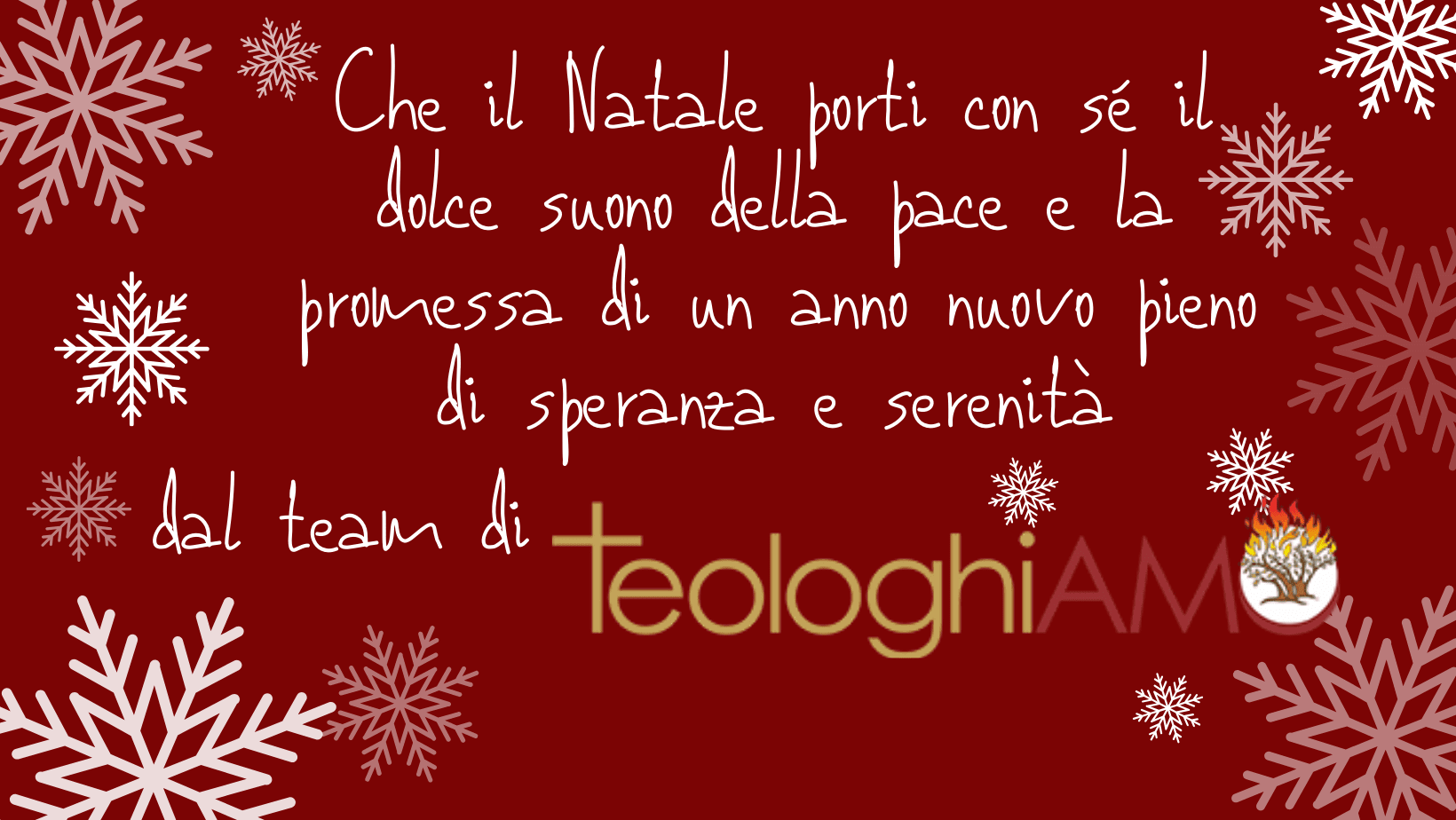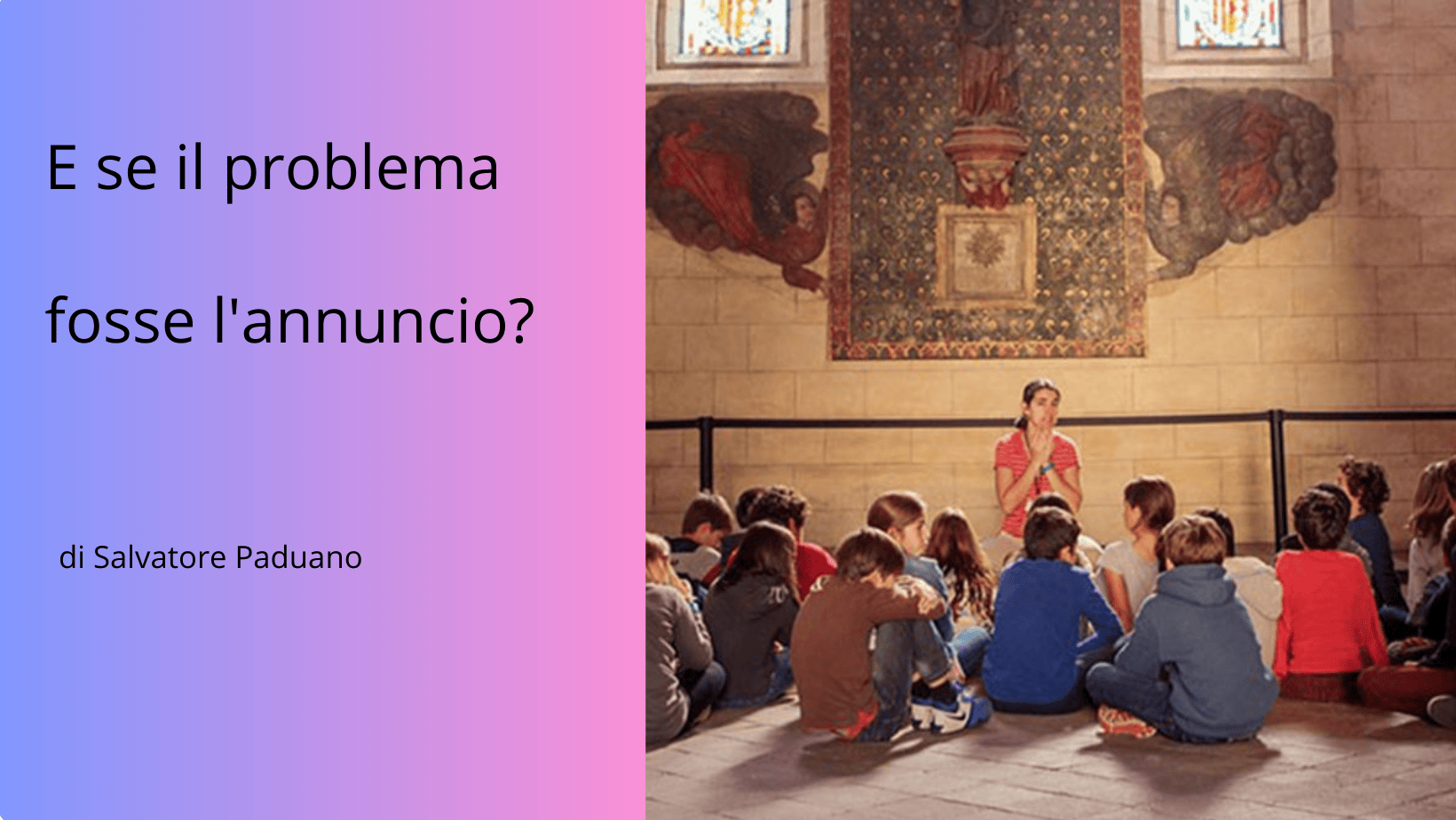Annunciare il Vangelo è da sempre stata una esortazione attribuita a Gesù ai suoi discepoli.
Il fenomeno, assai complesso, ha vissuto una vera evoluzione storica: il martire-testimone che offriva la vita per il vangelo lasciò il posto gradualmente all’asceta-mistico-filosofo alla ricerca di purificazione e perfezione; in una società identitariamente cristiana il testimone assunse poi il volto del difensore della retta dottrina, del divulgatore popolare, della mistica; nel Novecento acquisì rilievo la testimonianza “sociale” del vangelo e, con il Concilio Vaticano II, maggiore attenzione è stata attribuita ai laici testimoni.
Lo stesso fenomeno ha caratterizzato numerose discussioni e riflessioni interne alla comunità cristiana sin dai primi secoli: la libera vocazione battesimale all’annuncio ha causato equivoci, fraintendimenti, pericolose prospettive giudicate successivamente eterodosse; allo stesso modo, in ambito accademico non sono mancati testimoni che hanno disorientato le comunità e altri che hanno condotto la Chiesa sui giusti binari.
Annunciare il vangelo oggi
Annunciare il Vangelo oggi, nel mondo social e globalizzato ha riproposto il trend del messaggio da zapping o da tik tok, la ripetizione ad oltranza di contenuti triti e ritriti, in cui si innestano nuovi scenari popolari, esperienze di fede di prossimità spesso grezze o vicine al superstizioso.
L’invito a mettere i likes “o Maria non ti vuole bene”, a condividere “Solo se ami Gesù“, riporta a vecchie deformazioni di una fede che si confonde al paganesimo.
I percorsi di Sinodalità da anni riattivati nelle diocesi promuovono un nuovo modello di testimonianza attraverso il quale “discernere” l’annuncio, purificarlo da possibili contaminazioni e mode.
Ma la Sinodalità non piace a tutti e non gode di buona fama, perché riconduce all’essenza dell’annuncio cristiano: quando si annuncia, il soggetto è chiamato a defilarsi, relativizzarsi, farsi da parte. I protagonismi mistici, cari alle prime comunità (e che a volte ritornano come per il “caso Trevignano”), potrebbero così essere evitati per salvaguardare il “messaggio” cristiano che non può e non deve perdere il suo sapore originario.
Qualcuno potrebbe gridare “perle ai porci”.
Ti potrebbe interessare anche:
Il culto di Sant’Antonio Abate, tra fede, storia e folclore
Gennaio 16, 2025Giuseppe….l’uomo del coraggio e della cura
Dicembre 24, 2024Le perle ai porci
Aprile 23, 2024Le strade aperte da Papa Francesco, un pesante fardello per il futuro eletto
Maggio 6, 2025Eurovision Contest-ato
Maggio 13, 2024Attualmente insegna IRC nelle scuole secondarie a Roma, collabora con l'equipe pastorale di Porto Santa Rufina per la formazione e la catechesi. Già baccelliere in teologia presso la PFTIM San Tommaso, ha approfondito gli studi di licenza in cristologia dogmatica. Dottore in Lettere e filologia moderna, è coautore di un saggio sul pensiero teologico e politico su Lutero, Calvino e Zwingl