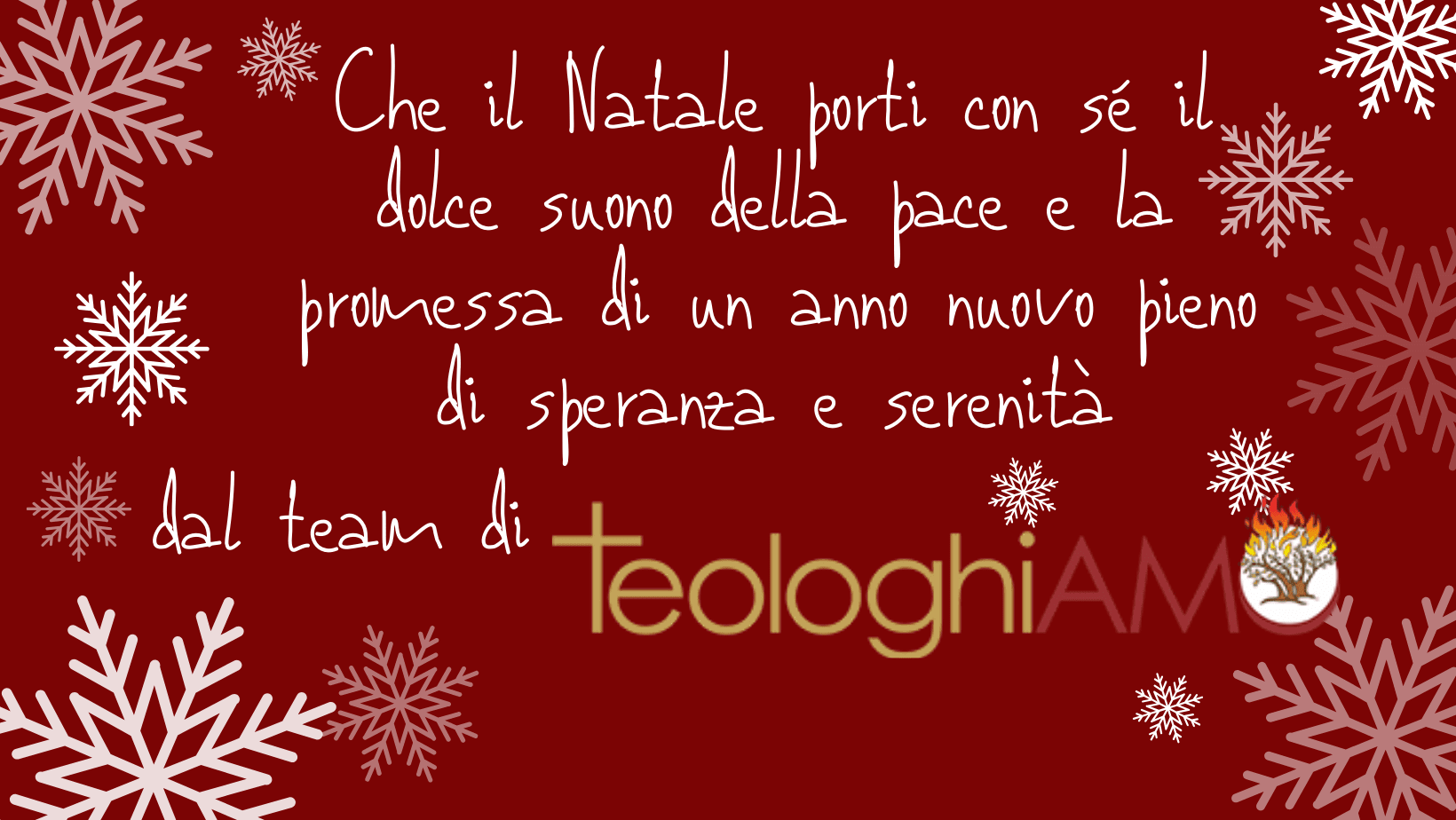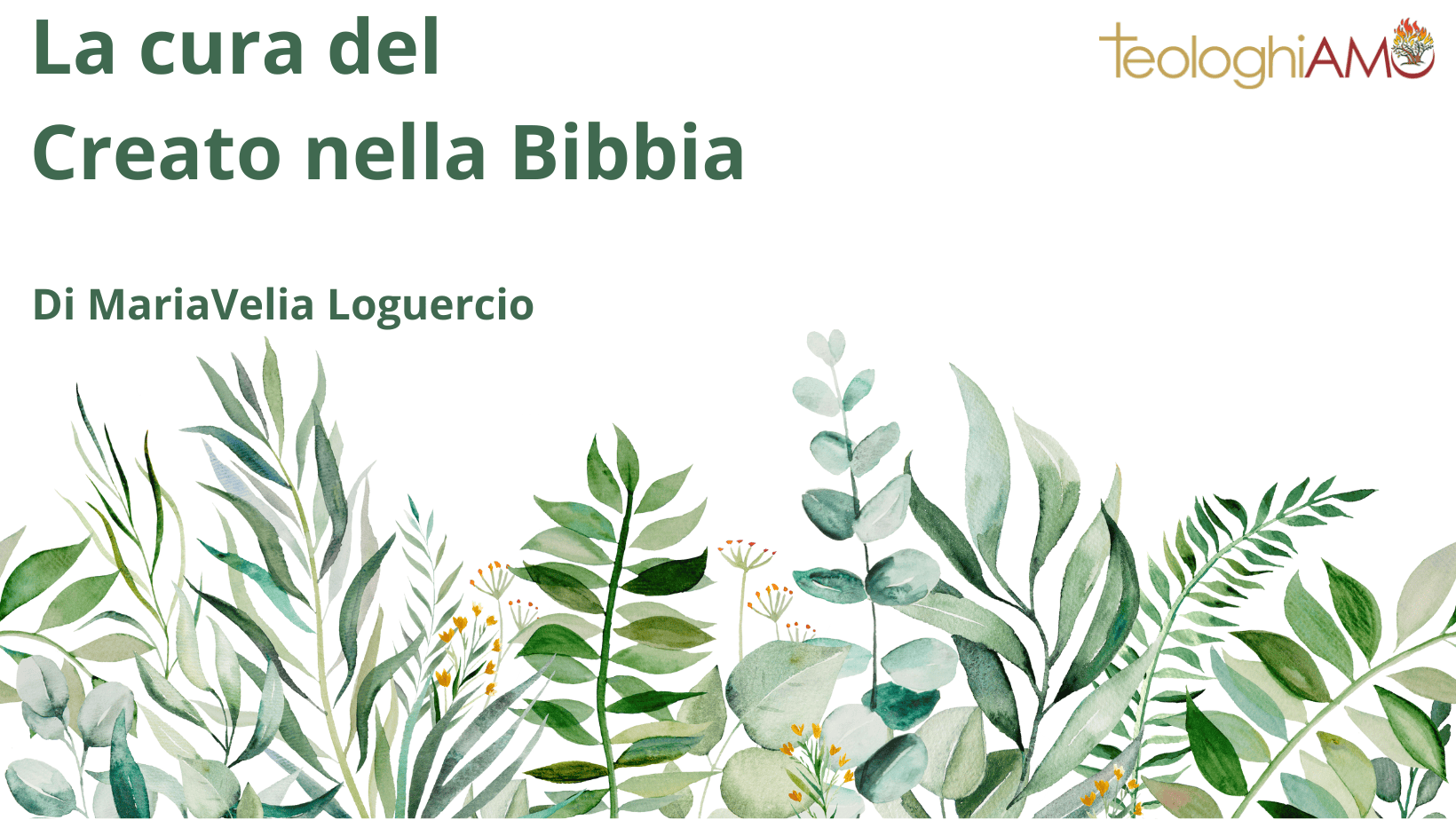A vari livelli e in modo trasversale, ormai da diversi anni, è cresciuta nella sensibilità comune la preoccupazione, e insieme la denuncia, per la situazione ambientale del nostro pianeta. Papa Francesco ha levato in maniera forte e decisa la sua voce contro lo scempio che si sta perpetrando ai danni della Terra con la promulgazione dell’enciclica “Laudato si” sulla cura della casa comune.
Francesco colpisce per la drammatica e lucidissima analisi dei danni e dei rischi ai quali l’assenza di un modello di ecologia sociale diffuso e condiviso sta esponendo la razza umana e questo pianeta. Il Papa, con il suo stile lucido e diretto, nei paragrafi che si succedono affronta i temi dell’inquinamento, del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la gravosa questione dell’acqua in maniera molto accurata.
La sintesi estrema è che il deterioramento etico e sociale della nostra società è la causa ultima del deterioramento ambientale.
La Centesimus Annus
Papa Francesco però non è il primo Papa ad affrontare questioni relative alle problematiche ambientali: san Giovanni Paolo II, ad esempio, in numerose occasioni si pronunciò sul dovere del cristiano di custodire la natura, l’ambiente e nella sua enciclica Centesimus Annus del 1991, parlò della natura come dono di Dio e della necessità che l’uomo collabori con Dio nel promuovere uno sviluppo ordinato e fiorente dell’ambiente (p.37).
Inoltre, è stata proprio la Centesimus Annus a tracciare una connessione tra “ecologia ambientale” ed “ecologia umana” (p.38) anticipando il concetto di ecologia integrale così centrale nella Laudato Si”.
Anche Papa Benedetto XVI ha richiamato gli stessi insegnamenti più volte durante il suo pontificato, come ad esempio nella sua enciclica “Caritas in Veritate” del 2009 (48-52).
La Laudato Si
La Laudato Si, con la sua visione di un approccio integrato tra le persone e l’ambiente, ha radici nella storia del pensiero cattolico , in particolare nella Dottrina Sociale della Chiesa, l’enciclica infatti, oltre ad essere un’enciclica ambientalista è un’enciclica sociale che si inserisce quindi a pieno titolo nella scia della Dottrina sociale della Chiesa, per Francesco infatti non esistono una crisi sociale, una economica e una crisi ambientale distaccate le une dalle altre, ma tutte e tre sono strettamente interconnesse.
Certamente la Laudato Si rappresenta uno spartiacque per quanto riguarda la sensibilizzazione del mondo cristiano cattolico ai temi della tutela del creato, oltre ad essere la prima enciclica interamente dedicata alle tematiche ambientali, così questo tema è stato tanto preso a cuore dalla riflessione teologica da dare vita ad un nuovo ramo della teologia detto appunto ecoteologia.
La giornta mondiale di preghiera per la Custodia del Creato
Così a partire dall’anno di promulgazione della Laudato Si, Papa Francesco, allineandosi ad una prassi già consolidata nella Chiesa Ortodossa, ha scelto di istituire il 1 settembre la Giornata Mondiale di preghiera per la Custodia del Creato, facendola coincidere con quella ortodossa in pieno spirito ecumenico.
Essa infatti fu istituita nel 1989 dal Patriarca di Costantinopoli Dimitrios I. Anche il suo successore, Bartolomeo è sempre stato particolarmente attento al problema della salvaguardia dell’ambiente, esprimendosi, spesso in maniera anche molto forte, nei confronti dei grandi del mondo incapaci di dare risposte concrete alla crisi in atto: “È inconcepibile oggi che si adottino decisioni economiche senza tener conto anche delle loro conseguenze ecologiche. Lo sviluppo economico non può rimanere un incubo per l’ecologia” Affermava Bartolomeo in occasione del suo messaggio per la giornata di preghiera per la salvaguardia del creato del 2020.
Quest’anno, nel decimo anniversario della Laudato SI, il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata Mondiale di preghiera per la custodia del creato è “Semi di pace e di speranza”. ( a questo link il messaggio di Papa Leone XIV. ndr)
Ognuno è chiamato alla cura del Creato
Dopo questa breve introduzione, quello che vorrei sottolineare con questo mio breve intervento, anche a partire dalle parole stesse della Laudato Si, è come la responsabilità di ogni uomo e di ogni donna per quanto concerne la cura del creato affondi le proprie radici nell’annuncio biblico, nel testo della Bibbia. Non c’è uomo o donna che non sia chiamato a prendersi cura del pianeta, ma chi si nutre della Parola di Dio, ha ricevuto e riceve una chiamata alla cura che sta al “Principio”, e che è “lampada per i suoi passi” (Sal 119).
Quello che faremo quindi è analizzare i capitoli 1 e 2 di Genesi che contengono i racconti di creazione e cercare di comprendere, con una giusta interpretazione ed ermeneutica del testo biblico, cosa la Scrittura afferma in merito al rapporto dell’uomo e della donna con il creato.
Vorrei partire proprio dal titolo del mio intervento e soffermare la mia e la vostra attenzione su un termine: creato! Noi non abbiamo scritto “la cura della natura nella Bibbia” o “la cura dell’ambiente nella Bibbia”, ma abbiamo scelto un vocabolo ben più pregno di significato, quello di creato. Parlare di creato implica due importanti risvolti:
- Parlare di creato implica la fede in un Creatore, in una Sapienza che ha ordinato la realtà, una Sapienza che ancora oggi è possibile scorgere nel mondo che ci circonda e che ha agito spinta dall’amore.
- Parlare di creato permette all’uomo di recuperare la dimensione della co-creaturalità, l’uomo è una creatura, come tutte le altre plasmate dalla volontà del Creatore. Non è lui che ha creato la realtà, non è lui il dominatore dell’universo!
A questo punto vorrei inserire una spiegazione breve dei due racconti di creazione.
Nel capitolo II dell’enciclica Laudato Si al numero 67 il Papa afferma:
“Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un’accusa lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature”.
Genesi 1,28
Secondo molti Gn 1, 28 e il suo invito rivolto all’uomo di dominare la terra avrebbe avuto un influsso determinante e nefasto sulla cultura occidentale e sarebbe la ragione di un rapporto di sfruttamento dell’uomo ai danni della natura. Per questo è necessario cercare di interpretare in maniera corretta il senso del verbo dominare, nel suo contesto e con una giusta ermeneutica. La radice ebraica da cui deriva l’imperativo iussivo “weyirdù” (e domini….) è Radah.
Il verbo radah può essere tradotto con dominare o sottomettere quando il verbo è accompagnato da altre parole del campo semantico della violenza, come per esempio in Is 14,6:
“ di colui che percuoteva i popoli nel suo furore,con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro”.
Ma questo non è il caso di Gn 1,28, dove non sono presenti dei termini sinonimi o appartenenti al campo semantico della violenza.
Il verbo radah può essere inoltre tradotto con comandare o governare, il termine farebbe qui riferimento al re che governa con giustizia e diritto, ma non con la violenza! È questo il significato del verbo utilizzato in alcuni dei Salmi regali.
Inoltre nel MOA e nella Bibbia il verbo governare implica spesso una responsabilità nei confronti di Dio.
Interpretando quindi in maniera corretta il verbo radah possiamo dunque concludere che Dio non ordina all’essere umano di essere il dominatore della terra, né di calpestarla o di uccidere gli animali, al contrario l’uomo e la donna, proprio perché creati ad immagine e somiglianza di Dio, sono chiamati ad avere cura e a sostenere, a governare, il creato loro affidato da Dio.
In corrispondenza con il racconto di Gn 1 dobbiamo leggere anche il racconto di Gn 2, il secondo racconto di creazione, e quello che ci dice in riferimento al rapporto dell’uomo e della donna con il creato.
Genesi 2,8
In questo secondo racconto di creazione che, dal punto di vista cronologico è il più antico, si legge:
“il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato (Gn 2,8).
L’azione creatrice di Dio consiste nel piantare alberi, fiori, creare un bellissimo giardino e mettere l’uomo in relazione con esso. Leggendo Gn 2 l’immagine che può sopraggiungere nella nostra mente è quella di un Dio giardiniere, con le mani intrise di terra (l’adamah) per lavorarla, aprirla, farla morbida per i semi, un Dio artigiano che impasta la polvere del suolo e la modella plasmando l’uomo, l’adam.
“Noi siamo terra, unitamente alle eterne radici” scrisse D. M. Turoldo.
Il tema della cura del creato, adombrato nel primo racconto da quel “dominate” come abbiamo visto cattivamente interpretato, emerge in tutta la sua forza nel secondo racconto: “lo collocò nel giardino perché lo custodisse e lo coltivasse”….è proprio su questi due verbi che adesso focalizzeremo la nostra attenzione.
CUSTODIRE (shamar)
Il giardino che Dio affida all’uomo va custodito perché ha dei nemici, come ad esempio il deserto intorno a sè. Qui il testo biblico crea un’importante connessione tra Gn 2 e Gn 4 (la storia di Caino e Abele): il giardino va custodito con la stessa cura richiesta per il fratello. “Il Signore disse a Caino: dov’è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello?” (Gn 4,9).
La stessa radice Shamar è utilizzata dalla Bibbia per la cura del giardino e per quella del fratello, la cura è una sola, espressa appunto con lo stesso verbo. Gn 2, che esprime la relazione uomo-giardino e Gn 4 che esprime la relazione tra fratelli vanno letti insieme.
Il prendersi cura della terra va di pari passo con il prendersi cura del fratello. Quando tu non ti prendi cura diventi fratricida come Caino. Una terza via alla cura del creato e del fratello è la via dell’indifferenza, ma l’indifferenza partorisce violenza. Quando non custodisci il fratello, tu ferisci la terra…il grave peccato compiuto da Caino ha come prima conseguenza che la terra non è più feconda, non è più madre: “e quando lavorerai il suolo esso non ti darà più i suoi frutti (Gn 4,12).
Il suolo è reso sterile dal sangue di Abele. È davvero impressionante la coesione che la Scrittura stabilisce tra la terra e Abele: muore Abele e muore la terra!
Chi non si prende cura dei fratelli, fragili e poveri, non resta semplicemente al di fuori della storia, ma in qualche modo, direttamente o indirettamente, lascia morire la terra. E viceversa: se tu avveleni, depredi e sporchi la terra, se sprechi il bene prezioso dell’acqua, tu non ferisci solo la terra ma uccidi o lasci morire il fratello.
Il male fatto ad una sola creatura si ripercuote su tutto, così come il bene fatto ad una sola creatura si ripercuote su tutto l’immenso arazzo dell’essere.
La Bibbia è infinita anche per questa sua capacità di tenere insieme la terra e il fratello, la fraternità cosmica e la fraternità umana, una delle grandi intuizioni della Laudato S’’ è tenere insieme il grido dei poveri e il grido della terra, connessi in un unico gemito.
L’altro verbo che si riferisce al rapporto dell’uomo con il giardino è il verbo COLTIVARE, abad.
COLTIVARE (abad).
Coltivare e culto in ebraico hanno la stessa radice, abad, che può essere tradotta anche con servire…l’uomo quindi non solo è chiamato a custodire il giardino, ma è chiamato anche a servirlo: il primo culto che l’uomo rende a Dio non nasce nel Tempio, ma nel giardino. SERVIRE LE CREATURE è COLLABORARE CON IL CREATORE. Coltivare il giardino ha l’obbiettivo di far fiorire la vita in tutte le sue forme, di farla fruttificare, coltivare il giardino rende l’uomo co-creatore con Dio.
La Bibbia sottolinea quindi come ogni figlio di Adamo, ogni uomo, abbia la stessa vocazione: essere nella vita donatore di vita.
San Benedetto e San francesco
Nella storia del cristianesimo il passaggio dal paradigma del dominio (dominate e soggiogate), a quello della cura (custodite e coltivate che significa servite) ha comportato un lungo lavoro, sorretto particolarmente dal filone monastico: San Benedetto riassume in estrema sintesi la vita del monaco con il motto ora et labora, o secondo altre versioni ora et ara, una endiadi che unisce come in origine il culto A Dio e la coltivazione della terra.
San Bernardo ha guidato i cistercensi alla scuola del creato per attingervi la sapienza del vivere: gli alberi e le rocce vi insegneranno cose che mai potreste apprendere sui libri.
San Francesco nel suo grandioso cantico chiama tutte le creature fratelli e sorelle e la terra la madre bella che ci accoglie tra le sue braccia
Conclusioni
Alla fine di questo percorso che certamente non pretende di essere esaustivo del tema, ma che spera di aver suscitato in voi qualche suggestione, quale conclusione possiamo trarre riguardo al messaggio di questi due capitoli di Gn?
Ogni uomo e ogni donna che si dicono cristiani, che si mettono alla sequela della Parola non possono che considerare il creato come quel giardino affidato da Dio all’Adam, da custodire e da servire affinché possa continuare a portare vita, per il cristiano la salvaguardia dell’ambiente, la cura della nostra casa comune, è un imperativo categorico che affonda le sue radici nella Parola stessa di Dio…
Nessun cristiano oggi può rimanere indifferente davanti al grido della terra perché la posta in gioco non è migliorare la qualità di vita su questo pianeta, ma fare in modo che la vita continui ad essere possibile!
Ti potrebbe interessare anche:
Talebani, scuola e religione
Ottobre 8, 2021«Nulla va rifiutato» (1Tim 4,4)
Gennaio 23, 2024Le strade aperte da Papa Francesco, un pesante fardello per il futuro eletto
Maggio 6, 2025Parte in Campania il Festival della Teologia: luglio e agosto nel segno della Speranza
Luglio 11, 2025Il misterioso fenomeno "The Chosen"
Marzo 4, 2024Teologa, studiosa di ebraismo e appassionata di astronomia. Impegnata da anni nel dialogo Interreligioso, docente di religione e docente di ebraico ed esegesi dell’A.T. presso ISSR San Matteo (SA).