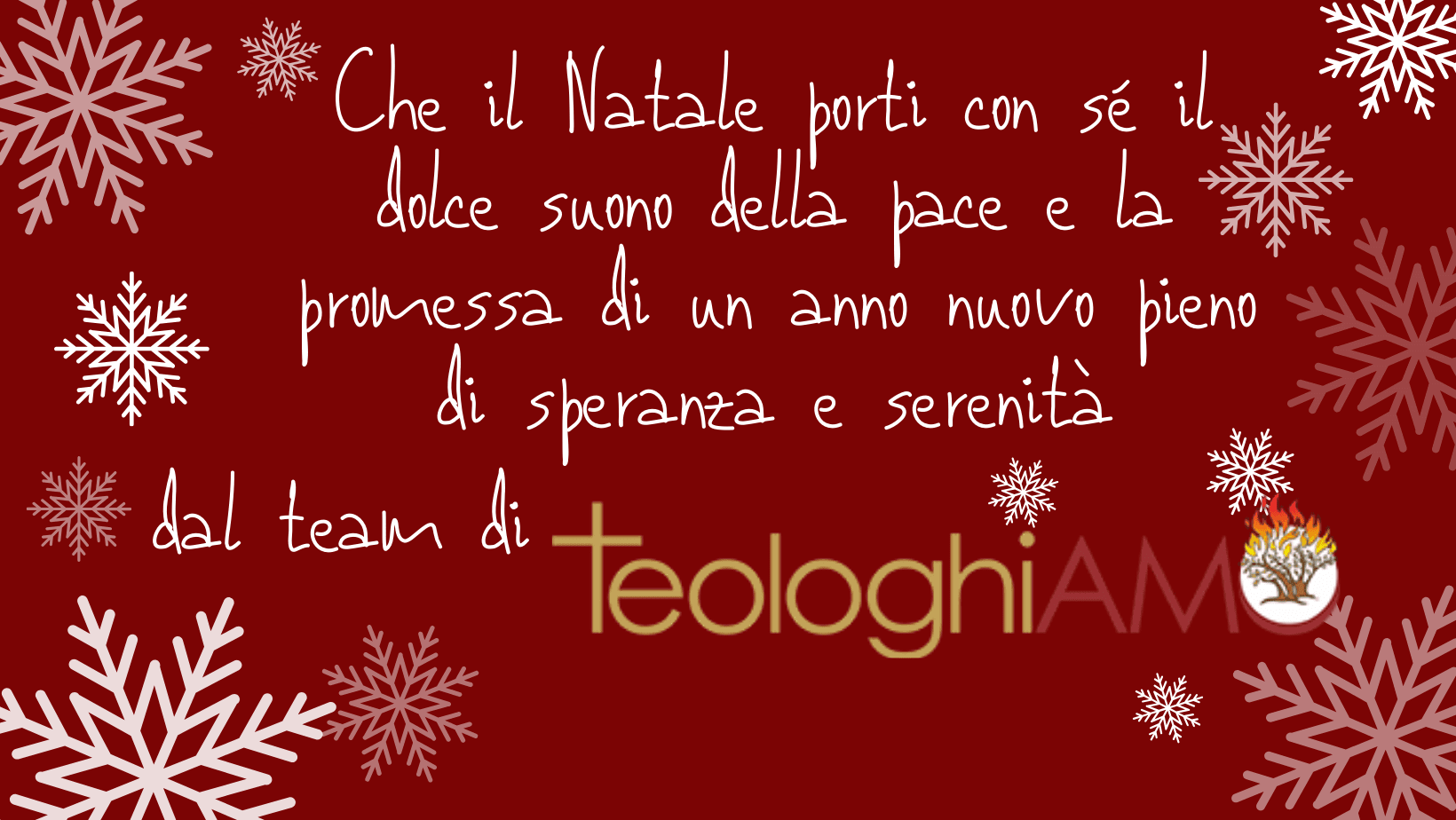L’elezione di Leone XIV mi ha riportato alla mente come il pensiero di Sant’Agostino rappresenti un crocevia tra l’eredità platonica e l’antropologia cristiana, potremmo dire oggi tra il mondo contemporaneo e la bellezza del messaggio cristiano.
In questo quadro, l’eros – inteso come desiderio umano, tensione verso l’altro e ricerca del bene – assume un ruolo complesso. Lungi dall’essere semplicemente condannato, come spesso ritengono oggi coloro che non hanno avuto l’opportunità di studiare il concetto di eros nel Cristianesimo, l’eros secondo Agostino deve essere purificato, rediretto e trasfigurato nella caritas, l’amore cristiano.
Il concetto di eros, centrale nella filosofia greca – da Platone ad Aristotele – subisce, con Agostino, una trasformazione radicale. In Platone l’eros è una forza ascensionale che muove l’anima verso il Bene e l’Assoluto. In Agostino, invece, l’eros non è negato, ma sottoposto a una purificazione interiore: diventa il segno di una mancanza ontologica che può essere colmata solo da Dio.
Agostino eredita e critica la nozione greca di eros, rielaborandola alla luce dell’esperienza cristiana e della sua personale conversione: l’uomo desidera ciò che non ha, e Dio è l’unico oggetto capace di soddisfare pienamente questo desiderio.
Fin dall’incipit delle Confessioni, il tema dell’inquietudine interiore è centrale: “Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te.” (Confessiones, I, 1, 1). Questa affermazione definisce l’ontologia del desiderio umano.
Il cuore dell’uomo è “inquieto”, agitato, assetato. L’eros non è, per Agostino, una colpa in sé, ma una tensione naturale, che può però diventare distorta se orientata verso beni finiti. L’errore dell’eros quindi non risiede nel desiderare, ma nell’amare male.
Nella sua giovinezza, Agostino come tanti uomini e donne di oggi, sperimenta un eros possessivo, confuso con la concupiscenza: “Amare ed essere amato mi pareva più dolce che non il vino.” (Confessiones, II, 2). Ma l’esperienza del peccato lo conduce alla comprensione che l’amore vero non è brama di possesso (cupiditas), bensì dono di sé (caritas).
Questa distinzione tra cupiditas e caritas è centrale in tutta la sua riflessione etica e teologica. La cupiditas è l’eros che si piega su sé stesso, che vuole possedere. La caritas è l’eros redento, che si eleva a Dio e si apre al prossimo.
In Sant’Agostino, l’eros non è rigettato in quanto tale, ma viene sottoposto a discernimento e conversione. Ecco perchè il filosofo africano distingue nettamente tra due forme di amore: cupiditas e caritas, che rappresentano due orientamenti opposti dell’eros.
La cupiditas è l’amore egoista, rivolto a sé stessi o ai beni finiti in modo possessivo, è l’amore della città terrena (civitas terrena), nel dualismo agostiniano tra città dell’uomo e città di Dio. Deriva dal disordine introdotto dal peccato originale: l’uomo, anziché desiderare Dio, si ripiega sul proprio piacere.
Il desiderio si fa brama (concupiscentia), soprattutto in campo sessuale, come Agostino ammette autobiograficamente nelle Confessioni (libro II). “Io non amavo ancora, ma amavo l’amore…” (Confessiones, III, 1,1). La caritas invece è l’amore che proviene da Dio e ritorna a Dio. È l’eros trasfigurato: un amore gratuito, oblativo, ordinato, che si realizza nel dono di sé e nella ricerca del bene dell’altro.
Nel De Trinitate, Agostino sviluppa e approfondisce una teologia dell’amore in chiave trinitaria, egli definisce Dio come Amante, Amato e Amore (De Trinitate, VIII, 10, 14). Questa triade mostra che l’eros ha una radice divina, poiché Dio stesso è relazione amorosa. Allo stesso modo, però l’uomo, creato a immagine di Dio, è chiamato a replicare questa struttura relazionale anche nel proprio modo di amare, perchè l’amore vero non è isolamento, ma comunione e l’eros autentico è simile a Dio, tende all’unità, alla reciprocità, al dono.
Potremmo dire che sant’Agostino non cancella il desiderio, ma lo salva. L’eros, una volta convertito, non è più brama di possesso, ma energia relazionale, spirituale, che unisce l’uomo a Dio e al prossimo. In questo senso, la visione agostiniana prelude alla sintesi tra eros e agape che sarà ripresa da autori come Benedetto XVI nell’enciclica Deus Caritas Est.
Nella sua prima omelia, Papa Leone XIV ha sottolineato che «la pace è un ordine dell’amore», richiamando l’idea agostiniana che la pace autentica nasce dalla giusta disposizione dell’amore: amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi.
Questo implica una trasformazione dell’eros da desiderio possessivo a forza che unisce e costruisce la comunità.
In linea con l’insegnamento di Benedetto XVI nell’enciclica Deus Caritas Est, Leone XIV quindi riconosce la necessità di integrare eros e agape. L’eros, inteso come desiderio di unione, deve essere purificato e orientato verso l’altro in un amore che si dona, superando l’egoismo e aprendosi alla comunione.
Questa visione si riflette anche nella sua posizione sulla famiglia, che ha suscitato già polemiche mediatiche. Il papa definisce la famiglia come «società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società», fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, la famiglia è il luogo privilegiato in cui l’amore umano, purificato e orientato, può esprimersi pienamente.
L’amore è sempre un cammino di conversione dell’eros in caritas, un processo di purificazione e orientamento del desiderio umano verso Dio e il prossimo, in una dinamica che unisce interiorità e relazionalità, fede e vita concreta!
Ecco perchè è auspicabile che “la Chiesa sia un faro che illumina le notti del mondo”, per guidare i fedeli nella trasformazione del loro desiderio in un amore che costruisce comunità, promuovendola giustizia e favorendo la riconciliazione
Ti potrebbe interessare anche:
Benedetti eretici
Marzo 12, 2023Rinascere nel mistero pasquale
Aprile 6, 2024È giunto il Messia?
Aprile 30, 2024Dio si è fatto come noi per farci come Lui
Dicembre 29, 2023Riconoscere la “dignità infinita” del malato e accompagnarlo nel suo dolore.
Luglio 18, 2024Teologa e consulente familiare, da anni docente di religione e della scuola di comunicazione e di Consulenza Familiare di Napoli. È direttore del Consultorio familiare Agape ODV e appassionata di teologia della famiglia e psicologia.